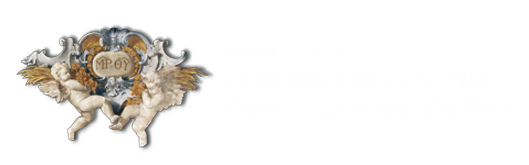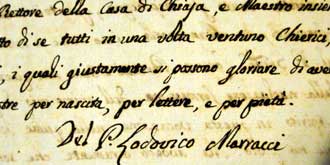 Si compiono in questi giorni i quattrocento anni dalla nascita di Ludovico Marracci (1612-1700) Sacerdote dell’Ordine della Madre, orientalista traduttore del corano e della Bibbia arabica. Per celebrare l’evento l’Ordine della Madre di Dio, il Centro studi OMD e diverse istituzioni ecclesiali accademiche e civili, cureranno un Convegno Internazionale di Studi a Roma il prossimo 15-16 novembre. La sapiente figura del Marracci seppe coniugare scienza e fede in un periodo storico in cui la Chiesa risentiva delle ricchezze e dei contraccolpi della modernità. P. Ludovico Marracci nasce a Torcigliano di Camaiore nella lucchesia il 6 ottobre 1612. Entrato a Roma fra i Chierici Regolari della Madre di Dio, studiò nel collegio romano di S. Maria in Campitelli le antiche lingue orientali in particolare l’arabo. Lui stesso racconta come apprese l’alfabeto dai “levantini” sulle rive del Tevere, da questi si fece insegnare la pronuncia; «il resto –afferma- l’ho appreso da per me senz’altri maestri». Siamo nella Roma del XVII secolo, crogiolo di razze e culture, nella quale era possibile trovare testi editi e manoscritti in arabo, ma anche studiosi che conoscevano la lingua dell’Islam.
Si compiono in questi giorni i quattrocento anni dalla nascita di Ludovico Marracci (1612-1700) Sacerdote dell’Ordine della Madre, orientalista traduttore del corano e della Bibbia arabica. Per celebrare l’evento l’Ordine della Madre di Dio, il Centro studi OMD e diverse istituzioni ecclesiali accademiche e civili, cureranno un Convegno Internazionale di Studi a Roma il prossimo 15-16 novembre. La sapiente figura del Marracci seppe coniugare scienza e fede in un periodo storico in cui la Chiesa risentiva delle ricchezze e dei contraccolpi della modernità. P. Ludovico Marracci nasce a Torcigliano di Camaiore nella lucchesia il 6 ottobre 1612. Entrato a Roma fra i Chierici Regolari della Madre di Dio, studiò nel collegio romano di S. Maria in Campitelli le antiche lingue orientali in particolare l’arabo. Lui stesso racconta come apprese l’alfabeto dai “levantini” sulle rive del Tevere, da questi si fece insegnare la pronuncia; «il resto –afferma- l’ho appreso da per me senz’altri maestri». Siamo nella Roma del XVII secolo, crogiolo di razze e culture, nella quale era possibile trovare testi editi e manoscritti in arabo, ma anche studiosi che conoscevano la lingua dell’Islam.Nel 1645 gli fu dato l’incarico dalla Congregazione di Propaganda Fide di seguire con una commissione di dotti la traduzione in arabo della Bibbia che portò alle stampe nel 1668. Nominato nel 1656 lettore alla cattedra di lingua araba presso la Sapienza di Roma, ebbe anche diversi incarichi nella curia romana. Fu confessore del Beato Innocenzo XI, Benedetto Odescalchi (1611-1689), di cui scrisse una biografia. Ma l’opera che ha legato il nome del Marracci all’Islam, rimane la traduzione latina del Corano. Essa nasce da un intento missionario e nello stesso tempo apologetico; il suo progetto fu di comprendere e di “condannare” semmai, dopo aver studiato e vagliato il punto di vista dell’avversario. Il metodo controversista ma anche la profonda curiosità di uomo di scienza e letterato forgiarono la personalità del Marracci dentro quella Roma cosmopolita nel cuore del seicento. La sua religiosità forgiata alla scuola del fondatore dei Chierici Regolari della Madre di Dio, S. Giovanni Leonardi (1542-1609), venne anche stimolata dal suo originale intuito: da una parte la riforma della Chiesa, dall’altra l’urgenza dell’annuncio missionario e una profetica “inculturazione” della fede.
Il Marracci non si limitò solo a tradurre il Corano, ma nel Prodromus, una sorta d’introduzione, stabilì un criterio fondamentale e programmatico: il testo non va tradotto «da parola a parola, ma da senso a senso». Per questo non occorreva conoscere solo l’arabo, ma il testo doveva essere avvicinato all’ampia tradizione islamica e ai “dotti commenti di autori arabi”. Nacque così l’Alcorani textus universis, opera che venne alla luce nel 1698 nella tipografia del Seminario di Padova, fondata dal cardinale Gregorio Barbarico (1625-1697).
Il ricordo di Ludovico Marracci ci spinge a riflettere sul “fatto coranico” e sulla sua incidenza culturale in questo nostro tempo . Non possiamo prescindere dal fatto che il testo sacro dell’Islam ha attinto parecchio dalla cultura giudaico-cristiana. Il problema della sua conoscenza non si pone soltanto adesso, con la presenza di uomini e donne provenienti dall’Islam o l’attenzione a quei moti popolari che ormai conosciamo come “primavera araba”. L’apertura e la sensibilità della Chiesa in questo campo esistono da sempre e l’esempio del Marracci, con le debite distanze storico-culturali, lo dimostra. L’incontro e il dialogo rimangono sempre le vie più importanti, se non altro per conoscersi tra credenti.